Mons. Athanasius Schneider: sulla Santa Comunione e su un possibile scisma
Intervista integrale rilasciata da S.E. Rev.ma Mons. Athanasius Schneider, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Santa Maria di Astana, a Sarah Atkinson, giornalista indipendente ed editore della rivista Mass of Ages (organo ufficiale della Latin Mass Society of England and Wales). Di questa intervista è stata pubblicata una sintesi sul sito Catholic Herald, e il testo integrale sul sito della stessa Latin Mass Society. Offriamo qui la traduzione del testo integrale inglese, ad opera della Prof. Eva Fabbri Baroncini, di Bologna.
MONS. SCHNEIDER: Per quanto riguarda la mia esperienza e la mia conoscenza, la ferita più grande nella crisi attuale della Chiesa è la ferita Eucaristica; gli abusi del Santissimo Sacramento.
Molta gente riceve la Santa Comunione in un oggettivo stato di peccato mortale… Questo si sta diffondendo nella Chiesa, specialmente nel mondo occidentale in cui la gente raramente si accosta alla Santa Comunione con una preparazione sufficiente.
Certa gente che si accosta alla Santa Comunione vive situazioni di moralità irregolare, che non corrispondono al Vangelo. Senza essere sposati, si accostano alla Santa Comunione. Può darsi il caso che siano divorziati e che vivano in un nuovo matrimonio, un matrimonio civile, e ciononostante si accostano alla Santa Comunione. Penso che questa sia una situazione molto, molto grave.
C’è anche la questione dell’oggettiva irriguardosa accoglienza della Santa Comunione. La cosiddetta nuova, moderna maniera di ricevere la Santa Comunione direttamente in mano è molto grave perché espone Cristo ad essere trattato in un modo enormemente banale.
C’è il doloroso fatto della perdita dei frammenti Eucaristici. Nessuno può negarlo. E i frammenti dell’ostia consacrata sono schiacciati dai piedi. Questo è orribile! Il Nostro Signore, nelle nostre chiese, viene calpestato! Nessuno può negarlo.
E questo accade su larga scala. Questo dev’essere considerato, per una persona che ha fede ed ama Dio, un fenomeno molto grave.
Non possiamo continuare come se Gesù non esistesse come Dio, come se esistesse solo il pane. Questa moderna pratica della Comunione in mano non ha niente a che fare con la pratica della Chiesa antica. La pratica moderna del ricevere la Comunione in mano contribuisce gradualmente alla perdita della fede cattolica nella presenza reale e nella transustanziazione.
Un prete e un vescovo non possono dire che questa pratica va bene. Qui è a rischio ciò che è più sacro, più divino e concreto sulla Terra.
D. Lei sta portando avanti questa posizione da solo?
MONS. SCHNEIDER: Sono molto dispiaciuto di sentirmi come uno che grida nel deserto. La crisi Eucaristica dovuta all’uso moderno della Comunione in mano è così evidente. Non è un’esagerazione. È ora che i vescovi facciano sentire le loro voci in difesa di Gesù Eucarestia che non ha voce per difendersi. Qui c’è un attacco a ciò che è più Santo, un attacco alla fede Eucaristica.
Certamente ci sono persone che ricevono la Santa Comunione in mano con molta devozione e fede, ma sono una minoranza. La massa delle persone sta perdendo la fede a causa di questa maniera banale di prendere la Santa Comunione come un cibo comune, come una patatina o un pezzo di torta. Tale maniera di ricevere la cosa più Santa qui sulla terra non è sacra e col tempo distrugge la profonda consapevolezza e la fede cattolica nella presenza reale e nella transustanziazione.
D. La Chiesta sta andando nella direzione opposta alla Sua?
MONS. SCHNEIDER: Sembra che la maggioranza del clero e i vescovi siano soddisfatti di quest’uso moderno della Comunione in mano e non realizzano i veri pericoli connessi a tale pratica. Per me questo è incredibile. Com’è possibile, quando Gesù è presente nei piccoli frammenti? Un prete e un vescovo dovrebbero dire: “Devo fare qualcosa, almeno per ridurre gradualmente tutto questo. Devo fare tutto quello che posso.” Sfortunatamente ci sono membri del clero che fanno propaganda all’uso moderno della Comunione in mano e a volte proibiscono il ricevere la Comunione sulla lingua e in ginocchio. Ci sono persino preti che discriminano coloro che si inginocchiano per ricevere la Santa Comunione. Questo è molto, molto triste.
C’è anche un incremento del furto delle ostie a causa della distribuzione della Comunione direttamente in mano. C’è una rete, un commercio del furto delle Sante Ostie e questo è facilitato dalla Comunione in mano.
Perché dovrei io, come prete e vescovo, esporre Nostro Signore a tale pericolo, a tale rischio? Se questi vescovi o preti (che approvano la Comunione in mano) possiedono qualcosa di valore, non la esporrebbero mai al grave pericolo di essere persa o rubata. Proteggono le loro case ma non proteggono Gesù e permettono che venga rubato così facilmente.
D. In base al questionario sul tema della famiglia, la gente si aspetta grandi cambiamenti…
MONS. SCHNEIDER: Su questo tema c’è molta propaganda, portata avanti dai mass media. Dobbiamo stare molto attenti. Ci sono i mass media ufficialmente anti cristiani in tutto il mondo. In quasi tutti i paesi trasmettono lo stesso contenuto delle notizie, con forse l’eccezione dei paesi africani, asiatici o nell’Europa dell’Est.
Solo in Internet si possono diffondere le proprie idee. Grazio a Dio che Internet esiste.
L’idea che si faranno cambiamenti nel matrimonio e in legge morale nel prossimo sinodo dei vescovi a Roma viene principalmente dai media anti cristiani. E alcuni membri del clero e dei cattolici collaborano con loro per diffondere le attese del mondo anti cristiano per un cambiamento della legge di Dio riguardo al matrimonio e alla sessualità.
È un attacco dal mondo anti cristiano ed è molto tragico e triste che alcuni membri del clero collaborino con loro. Per sostenere un cambiamento della legge di Dio, essi usano il concetto di misericordia sofisticamente. Ma in realtà questa non è misericordia, questa è crudeltà.
Non è misericordia, per esempio, se qualcuno sta male e lo si lascia in tale penosa condizione. Questa è crudeltà.
Io non darei, per esempio, dello zucchero ad un diabetico, per me sarebbe crudele. Io cercherei di toglierlo da questa situazione e dargli un altro cibo. Forse non lo gradirà all’inizio, ma sarà la cosa migliore per lui.
Quelli del clero che vogliono ammettere i divorziati e i risposati alla Santa Comunione operano con un falso concetto di misericordia. È paragonabile ad un dottore che dà al paziente dello zucchero anche se sa che ciò lo ucciderà. Ma l’anima è più importante del corpo.
Se i vescovi ammettono i divorziati e i risposati alla Santa Comunione, allora li confermano nei loro errori allo sguardo di Dio. Faranno persino tacere la voce della loro coscienza. Li spingeranno ancora di più nella loro situazione irregolare solo per il bene di questa vita temporale, dimenticandosi che dopo questa vita però c’è il giudizio di Dio.
Questo tema verrà discusso nel sinodo. È sull’agenda. Ma spero che la maggioranza dei vescovi abbia ancora abbastanza spirito e fede cattolica da respingere la proposta sopra menzionata e non accettarla.
D. Qual è la crisi di cui Lei parla?
MONS. SCHNEIDER: Questa è una crisi di più ampia portata rispetto alla ricezione del Sacratissimo Sacramento in sé per sé. Penso che questo problema del ricevere la Santa Comunione da parte dei risposati farà scoppiare e rivelare la vera crisi nella Chiesa. La crisi reale della Chiesa è l’antropocentrismo, dimenticandosi del Cristocentrismo. Infatti questo è il male più grande, quando l’uomo o il clero si mettono al centro quando celebrano la liturgia e quando cambiano la verità rivelata da Dio, per esempio riguardo al sesto comandamento e alla sessualità umana.
La crisi si rivela anche nella maniera con la quale è trattato il Signore Eucaristico. L’Eucarestia è al cuore della Chiesa. Quando il cuore è debole, tutto il corpo è debole. Così quando la pratica che riguarda l’Eucarestia è debole, allora il cuore e la vita della Chiesa è debole. E quando la gente non ha più una visione soprannaturale di Dio nell’Eucaristia allora essi inizieranno ad adorare l’uomo, e poi anche la dottrina cambierà a piacimento dell’uomo.
Questa crisi è quando ci mettiamo, inclusi i preti, al centro e quando Dio è messo in un angolo e questo succede anche fisicamente. A volte il Santissimo Sacramento è posto in un armadietto lontano dal centro e la sedia del prete è al centro. Siamo in questa situazione già da 40 o 50 anni e c’è il reale pericolo che Dio, i suoi Comandamenti e le sue leggi saranno messe da parte e il desiderio umano naturale al centro. C’è una connessione causale tra la crisi Eucaristica e quella dottrinale.
Il nostro primo dovere come esseri umani è adorare Dio, non noi, ma Lui. Sfortunatamente, la pratica liturgica degli ultimi 40 anni è stata molto antropocentrica.
Partecipare alla liturgia è innanzitutto non fare cose ma pregare e adorare, amare Dio con tutta l’anima. Questa è vera partecipazione, essere uniti a Dio nella propria anima. La partecipazione esteriore non è essenziale.
La crisi è veramente questo: non abbiamo messo Cristo o Dio al centro. E Cristo è Dio incarnato. Il nostro problema oggi è che mettiamo da parte l’incarnazione. L’abbiamo eclissata. Se Dio rimane nella mia mente solo come un’idea, questa è Gnosi. Nelle altre religioni come per gli ebrei, musulmani, Dio non è incarnato. Per loro, Dio è nel libro ma Lui non è concreto. Solo nel Cristianesimo, e specialmente nella Chiesa Cattolica, l’incarnazione è pienamente realizzata e questo deve perciò essere sottolineato in ogni punto della liturgia. Dio è qui e veramente presente. Perciò ogni dettaglio ha importanza.
Viviamo in una società non cristiana, in un nuovo paganesimo. Oggi la tentazione per il clero è di adattarsi al nuovo mondo, al nuovo paganesimo, essere collaborazionisti. Siamo in una situazione simile a quella dei primi secoli, quando la maggioranza della società era pagana e il Cristianesimo era discriminato.
D. Pensa di vedere tutto questo a motivo della Sua esperienza in Unione Sovietica?
MONS. SCHNEIDER: Sì, (so cosa significa) essere perseguitati, testimoniare che sei Cristiano.
Siamo una minoranza. Siamo circondati da un mondo pagano molto crudele. La tentazione e la sfida di oggi può essere paragonata a quella dei primi secoli. Ai Cristiani veniva chiesto di accettare il mondo pagano e di mostrare ciò mettendo un grano di incenso nel fuoco di fronte alla statua dell’Imperatore o di un idolo pagano. Ma questa era idolatria e nessun buon Cristiano gettò alcun grano d’incenso. Preferirono dare le proprie vite, persino i bambini, i laici che erano perseguitati diedero le loro vite. Sfortunatamente nei primi secoli c’erano membri del clero e persino vescovi che gettarono grani d’incenso di fronte alla statua dell’Imperatore o di un idolo pagano o che consegnarono i libri della Sacra Scrittura per essere bruciati. Tali Cristiani collaborazionisti e chierici venivano chiamati a quei tempi “thurificati” o “traditores”.
Ora, ai nostri giorni la persecuzione è più sofisticata. Ai cattolici o al clero non è chiesto di mettere incenso di fronte ad un idolo. Sarebbe un gesto solo fisico/materiale. Ora, il mondo neo-pagano vuole che sostituiamo le nostre idee con le loro, come la dissoluzione del Sesto Comandamento di Dio, col pretesto della misericordia. Se alcuni membri del clero e i vescovi iniziano a collaborare con il mondo pagano oggi per la dissoluzione del Sesto Comandamento e nella revisione del modo in cui Dio creò uomo e donna, allora essi sono traditori della fede, stanno partecipando in definitiva ad un sacrificio pagano.
D. Può vedere una futura spaccatura nella Chiesa?
MONS. SCHNEIDER: Sfortunatamente, per alcuni decenni alcuni membri del clero hanno accettato queste idee del mondo. Ora tuttavia essi le stanno seguendo pubblicamente. Se tali cose continuano, penso, ci sarà una spaccatura all’interno della Chiesa di coloro che sono fedeli alla fede del loro battesimo e all’integrità della fede cattolica. Ci sarà una spaccatura con coloro che stanno prendendo in carico lo spirito di questo mondo e ci sarà una chiara spaccatura, penso. Si può immaginare che i Cattolici, che rimangono fedeli all’immutabile verità cattolica possano, per un periodo, essere perseguitati o discriminati anche a nome di chi ha potere nelle strutture esteriori della Chiesa? Ma le porte dell’inferno, cioè dell’eresia, non prevarranno contro la Chiesa e il Supremo Magistero certamente promulgherà un’inequivocabile sentenza dottrinale che respinge qualsiasi collaborazione con le idee neo pagane di cambiamento per esempio del Sesto Comandamento di Dio, il significato della sessualità e della famiglia. Allora alcuni liberali e molti collaboratori dello spirito di questo mondo, molti moderni “thurificati e traditores” lasceranno la Chiesa. Poiché la verità Divina porterà senza dubbio la chiarificazione, ci libererà e separerà nel mezzo della Chiesa i figli della Divina luce e i figli della pseudo luce di questo mondo pagano e anti cristiano. Posso supporre che tale separazione riguarderà ogni livello dei Cattolici: laici e persino senza escludere l’alto clero. Quei membri del clero che accettano oggi lo spirito del mondo pagano in materia di moralità e di famiglia si dichiarano Cattolici e persino fedeli al Papa. Dichiarano persino estremisti quelli che sono fedeli alla fede cattolica o quelli che promuovono la gloria di Cristo nella liturgia.
D. Pensa di essere stato definito estremista?
MONS. SCHNEIDER: Non sono stato dichiarato tale formalmente. Direi che tali membri del clero non sono in maggioranza ma stanno acquisendo influenza nella Chiesa. Sono riusciti ad occupare delle posizioni chiave in alcuni uffici della Chiesa. Tuttavia questo non è potere agli occhi di Dio. I veri potenti sono i piccoli nella Chiesa, quelli che conservano la fede.
Questi piccoli nella Chiesa sono stati delusi e trascurati. Hanno preservato la purezza della loro fede e rappresentano il vero potere della chiesa agli occhi di Dio e non quelli che hanno cariche di amministrazione. Grazie a Dio, il numero di questi piccoli sta crescendo.
Ho parlato, per esempio, con alcuni giovani studenti di Oxford e sono stato impressionato da questi studenti, ero così felide di vedere la loro purezza di fede, le loro convinzioni e la chiara mente Cattolica. Tali esempi e gruppi sono in crescita nella Chiesa e questo è il lavoro dello Spirito Santo. Questo rinnoverà la Chiesa. Perciò sono fiducioso e speranzoso anche riguardo alla crisi nella Chiesa. Lo Spirito Santo vincerà questa crisi con il suo piccolo esercito.
Non sono preoccupato per il futuro. La Chiesa è la Chiesa di Cristo e Lui è il vero Capo della Chiesa, il Papa è solo il Vicario di Cristo. L’anima della Chiesa è lo Spirito Santo e Lui è potente. Tuttavia ora noi stiamo facendo esperienza di una grave crisi nella Chiesa come è accaduto diverse volte in duemila anni.
D. Peggiorerà prima di migliorare?
MONS. SCHNEIDER: Ho l’impressione che sarà peggio. A volte le cose devono peggiorare e poi si vedrà il collasso di questo antropocentrismo, sistema clericale, che sta abusando del potere amministrativo della Chiesa, abusando della liturgia, abusando dei concetti di Dio, abusando della fede e della devozione dei piccoli nella Chiesa.
Poi vedremo l’ascesa di una Chiesa rinnovata. Questo si sta già preparando. Poi questo edificio clericale liberale crollerà perché non ha né radici né frutti.
D. Certa gente direbbe che Lei si preoccupa di cose non importanti, e riguardo i poveri?
MONS. SCHNEIDER: Questo è sbagliato. Il primo comandamento che Cristo ci ha dato era adora Dio solo. La liturgia non è una riunione di amici. È il nostro primo compito adorare e glorificare Dio nella liturgia e anche nel nostro modo di vivere. Da una vera adorazione ed amore di Dio si sviluppa l’amore per il povero e per il nostro vicino. È una conseguenza. I santi in duemila anni di Chiesa, tutti i santi che erano così devoti e pii, erano tutti estremamente misericordiosi con i poveri di cui si prendevano cura.
In questi due comandamenti ci sono tutti gli altri. Ma il primo comandamento è amare e adorare Dio e ciò è realizzato in modo supremo nella sacra liturgia. Quando si trascura il primo comandamento, allora non si sta facendo la volontà di Dio ma si sta accontentando se stessi. La felicità è eseguire la volontà di Dio, non eseguire la nostra volontà.
D. Quanto ci vorrà prima che la Chiesa venga rinnovata?
MONS. SCHNEIDER: Non sono un profeta. Possiamo solo ipotizzare. Ma, se si guarda alla storia della Chiesa, la crisi più grande fu nel quarto secolo con l’Arianesimo. Fu una crisi terribile, tutto l’episcopato, quasi tutto, collaborò all’eresia. Solo alcuni vescovi rimasero fedeli, si potevano contare sulle dita di una mano. Questa crisi durò più o meno 60 anni.
Poi la terribile crisi del cosiddetto secolo buio, il decimo secolo, quando il papato fu occupato da alcune famiglie romane molto malvagie ed immorali. Occuparono la sede papale con i loro figli corrotti e questa fu una crisi terribile.
Il successivo periodo di danni fu il cosiddetto esilio di Avignone e danneggiò molto la Chiesa, causando il grande scisma occidentale. Tutte queste crisi durarono circa 70-80 anni e furono molto gravi per la Chiesa.
Ora siamo, direi, nella quarta grande crisi, in una tremenda confusione riguardo alla dottrina e alla liturgia. Ci siamo già da 50 anni. Forse Dio sarà misericordioso con noi tra 20 o 30 anni? Eppure noi abbiamo tutta la bellezza delle verità divine, del divino amore e della grazia nella Chiesa. Nessuno può portarle vie, nessun sinodo, nessun vescovo, persino neppure un Papa può sottrarre il tesoro di bellezza della fede Cattolica, di Gesù Eucarestia, dei sacramenti. La dottrina immutabile, i principi liturgici immutabili, la sacralità della vita costituiscono il vero potere della Chiesa.
D. Il nostro tempo è visto come il periodo più liberale nella Chiesa…
MONS. SCHNEIDER: Dobbiamo pregare Dio che guidi la Sua Chiesa fuori da questa crisi e che dia alla Sua Chiesa apostoli che siano coraggiosi e santi. Abbiamo bisogno di difensori della verità e difensori di Gesù Eucarestia. Quando un vescovo difende il gregge e difende Gesù nell’Eucaristia, allora questo vescovo sta difendendo i piccoli nella Chiesa, non i potenti.
D. Perciò non le importa essere impopolare?
MONS. SCHNEIDER: È abbastanza insignificante essere popolare o impopolare. Per ogni uomo di chiesa il primo interesse è essere popolare agli occhi di Dio e non agli occhi di oggi o dei potenti. Gesù disse un avvertimento: Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
La popolarità è falsa. Gesù e gli apostoli rifiutarono la popolarità. I grandi santi della Chiesa, come i SS. Tommaso Moro e John Fisher, rifiutarono la popolarità e sono dei grandi eroi. E coloro che oggi sono preoccupati della popolarità attraverso i mass media e l’opinione pubblica, non saranno ricordati nella storia. Saranno ricordati come codardi e non come eroi della Fede.
D. I media hanno grandi aspettative da Papa Francesco…
MONS. SCHNEIDER: Grazie a Dio Papa Francesco non si è espresso in quel modo che i media si aspettano da lui; egli ha proclamato fino ad ora, nei suoi discorsi ufficiali, una dottrina cattolica molto bella; io spero che continui insegnare in modo molto chiaro la dottrina cattolica.
D. E sulla Comunicatio in Sacris con gli anglicani e gli altri?
MONS. SCHNEIDER: Ciò non è possibile, ci sono fedi differenti. La santa comunione non è un mezzo per raggiungere l'unità: è l'ultimo passo, non il primo passo.
Ciò sarebbe una desacralizzazione di ciò che è più santo. Naturalmente dobbiamo essere uno: abbiamo ancora nel credo alcune differenze sostanziali.
L'eucaristia è un segno di profondissima unità. La Comunicatio in Sacris con i non cattolici sarebbe una bugia, sarebbe contraria alla logica.
L’Ecumenismo è necessario per mantenere buone relazioni con i fratelli separati per amarli. In mezzo alla sfida del nuovo paganesimo, noi possiamo e dobbiamo collaborare con seri non cattolici per difendere la verità divina rivelata e la legge naturale creata da Dio
Sarebbe meglio non avere [una relazione strutturata] Stato-Chiesa, quando lo Stato governa la vita della Chiesa, come per esempio, nell’ambito della nomina del clero o dei vescovi. Una tale pratica di una Chiesa di Stato danneggerebbe la chiesa stessa. In Inghilterra per esempio, lo stato governa la Chiesa d'Inghilterra.
Quest'influenza dello Stato può corrompere spiritualmente e teologicamente la Chiesa: così è meglio essere liberi da una Chiesa di Stato così strutturata.
D. E sulle donne nella Chiesa?
MONS. SCHNEIDER: Le donne sono chiamate il sesso debole dato che sono fisicamente più deboli; comunque esse sono spiritualmente più forti e più coraggiosi degli uomini.
Ci vuole coraggio per dare alla luce un bambino, per questo Dio ha dato alla donna un coraggio che l'uomo non ha.
Naturalmente ci sono stati molti uomini coraggiosi in tempo di persecuzione.
Ancora oggi Dio ama scegliere i deboli per confondere i potenti; per esempio le donne eucaristiche delle quali io ho parlato nel mio libro È il Signore lavoravano nelle loro famiglie e desideravano aiutare i sacerdoti perseguitati in un modo veramente eccezionale.
Esse non avrebbero mai osato toccare le ostie sante con le loro dita. E se si sarebbero persino rifiutati di proclamare le letture durante la Messa
Mia madre per esempio, che ha ottantadue anni e vive in Germania, quando per la prima volta venne in occidente, rimase scioccata e scandalizzata nel vedere donne in presbiterio, durante la Santa Messa.
Il vero potere della donna cristiana e cattolica e il potere di essere il cuore della famiglia, chiesa domestica; di avere il privilegio di essere la prima che nutre il corpo del suo bambino e anche di essere la prima che dà il nutrimento all'anima dello stesso, insegnando le prime preghiere e le prime verità della fede cattolica.
La più prestigiosa tra le professioni che può svolgere una donna, è quella di essere madre e specialmente di essere una madre cattolica.
















.jpg)
























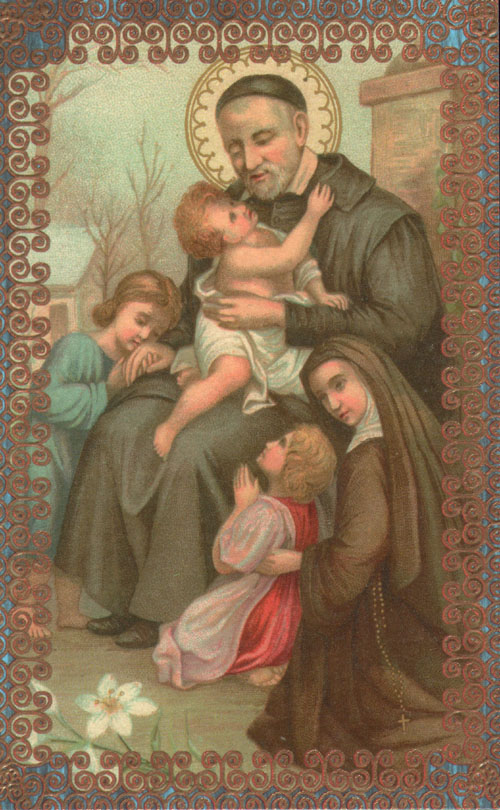



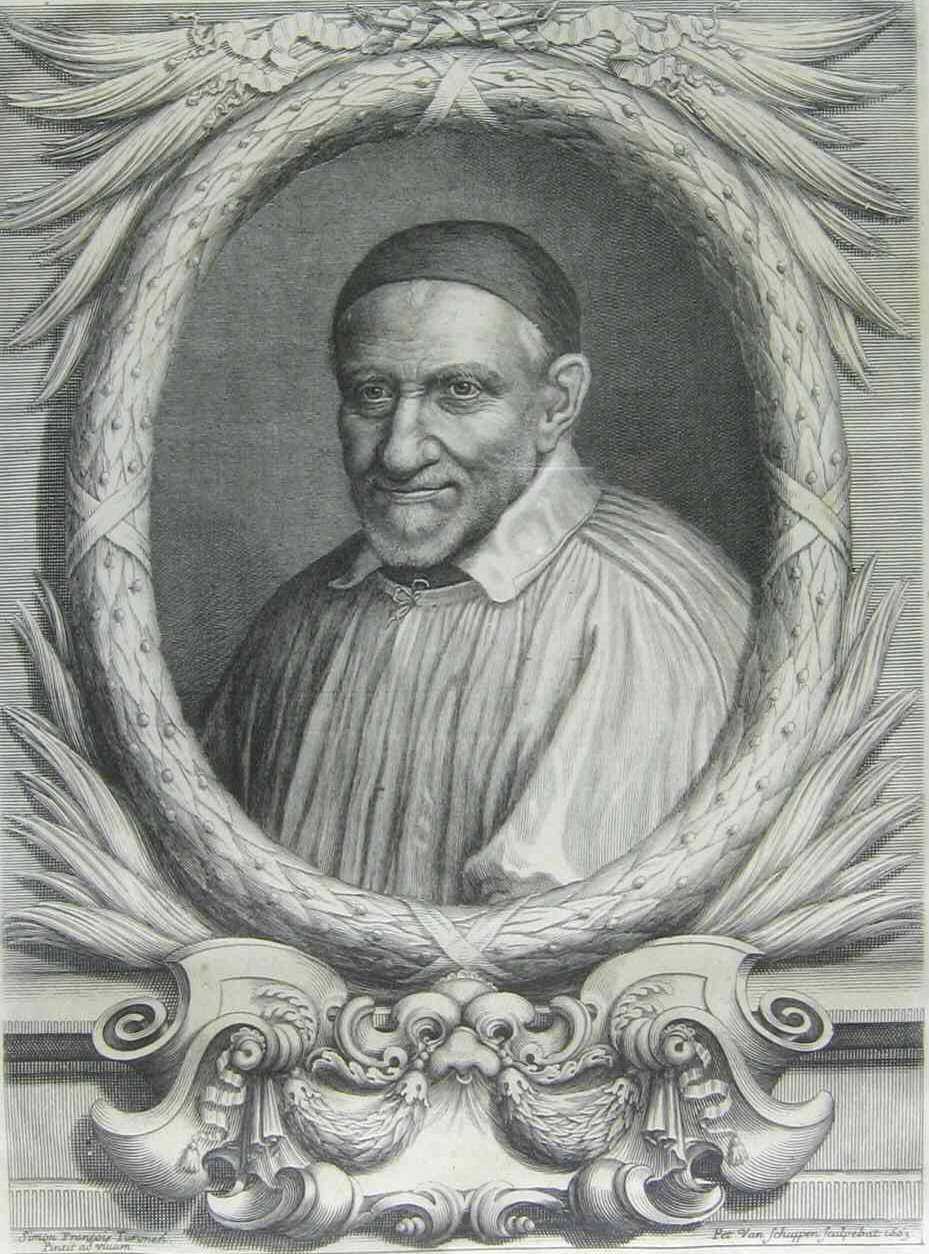








































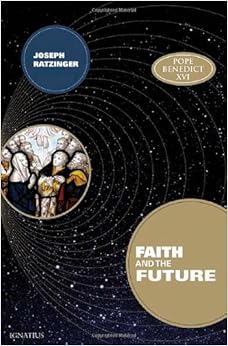





















.jpg)











