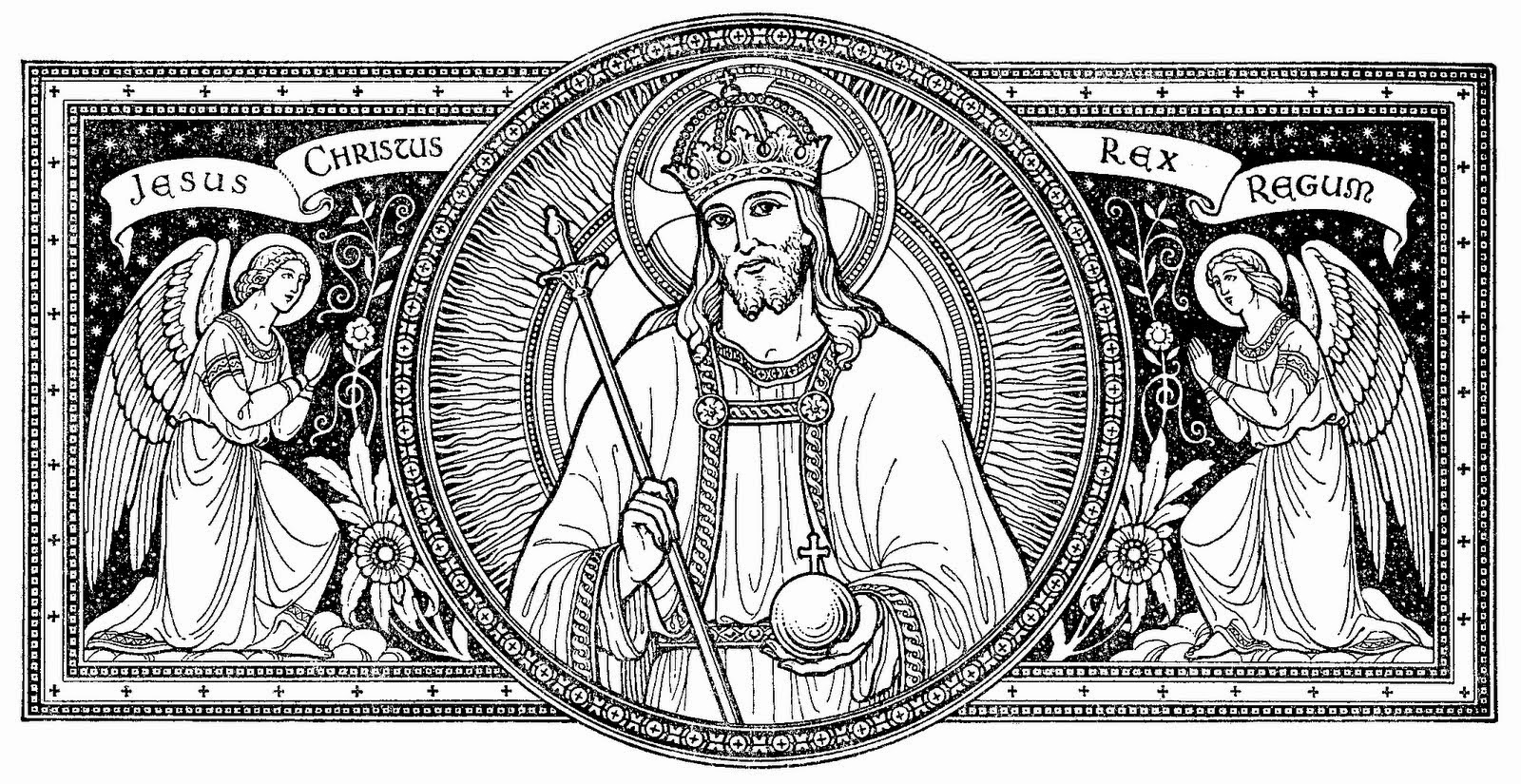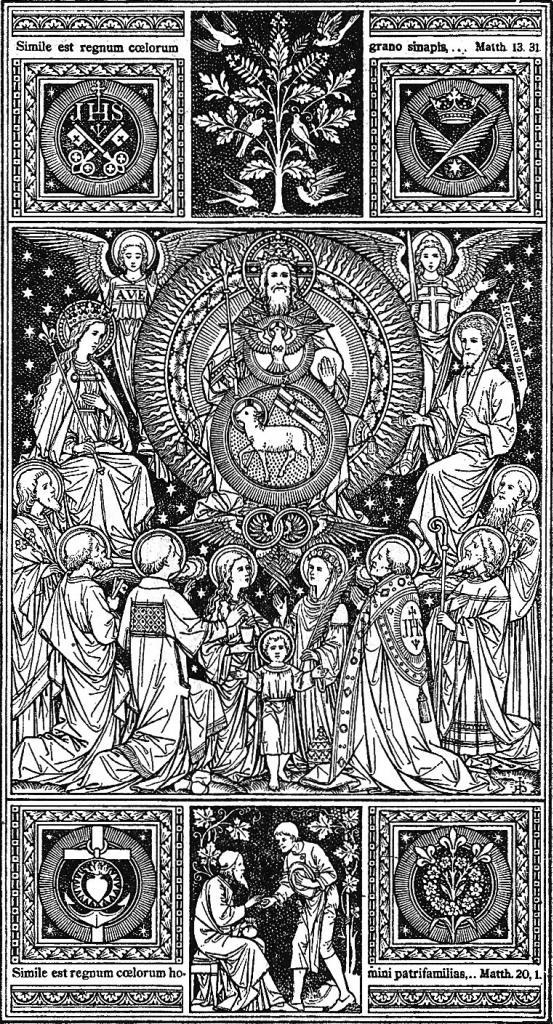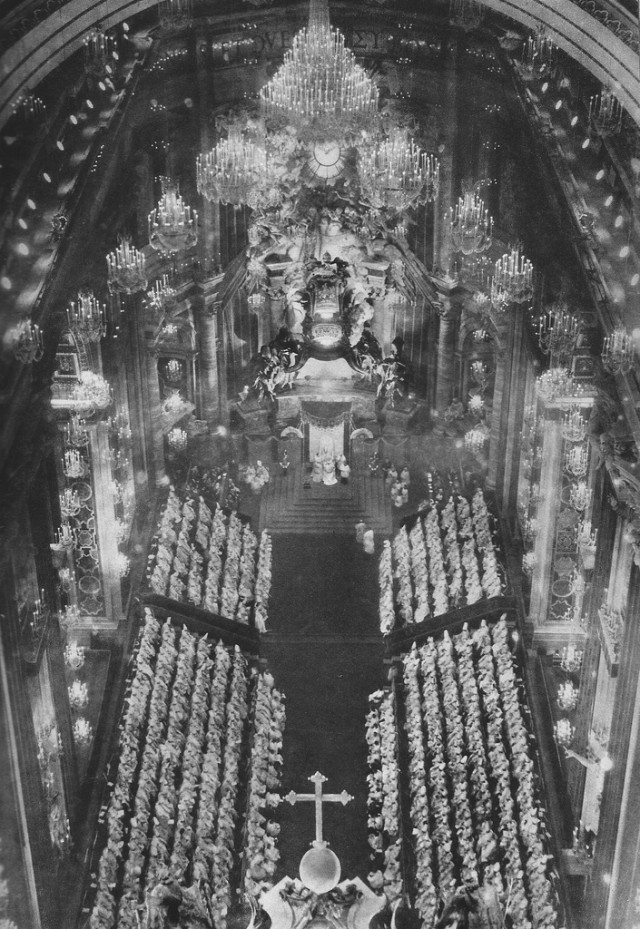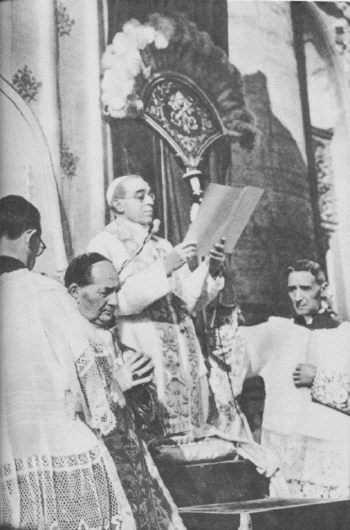Oggi, memoria liturgica tradizionale dei SS. Zaccaria ed Elisabetta, genitori del Precursore, su segnalazione, ben volentieri rilancio sul blog questo magistrale intervento del card. Brandmüller tenuto lo scorso 25 ottobre a Norcia.
* * * * * * *
ALL’EUROPA IN CRISI SERVE UNA «RIVOLUZIONE» CATTOLICA. IL CARDINALE BRANDMÜLLER SPIEGA PERCHÉ
Pubblichiamo lo splendido intervento del cardinale Walter Brandmüller, presidente emerito del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, alla giornata di commemorazione del 50° anniversario della proclamazione di san Benedetto patrono d’Europa, che si è tenuta sabato 25 ottobre a Norcia. Intervento sul tema «Il contributo della Chiesa al futuro dell’Europa».
di Walter Brandmüller
Da quando - avviato dai grandi europeisti e cattolici Adenauer, De Gasperi e Schumann - si è messo in moto il processo di unificazione europea, nelle conferenze, nelle pubblicazioni e così via, si evocano le radici cristiane dell’Europa, di quell’Europa la cui identità spirituale e culturale, cresciuta in questi due millenni, risale a un’eredità garantita dai nomi Atene, Gerusalemme e Roma. Di Mecca e Medina non si parlerà nel presente contesto.
Ma non è di questo che ci occuperemo oggi. Il nostro sguardo si volge piuttosto verso il futuro e domandiamo: che contributo può dare la Chiesa cattolica - che ci ha trasmesso questa eredità e continua a tramandarla ancora oggi - per plasmare l’Europa del futuro, affinché diventi degna dell’uomo, umana e quindi anche corrispondente alla volontà del Creatore?
Non dimentichiamo, poi, che la Chiesa non è solo annunciatrice del Vangelo di Gesù Cristo, ma si è sempre compresa anche come custode del patrimonio spirituale naturale, del vero, del buono e del bello. La grazia presuppone la natura. Perciò, ancor prima dell’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, il contributo della Chiesa al futuro dell’Europa consiste nel ripristino - per così dire - delle basi naturali della vita umana, della società umana.
LA REALTÀ SOCIALE ATTUALE
Per comprendere che si tratta di una necessità vitale è sufficiente uno sguardo anche solo superficiale alla realtà sociale attuale. Essa mostra, in tempi preindustriali, inaridimenti morali inimmaginabili.
Possiamo citare qualche esempio. La vita e la salute della popolazione vengono messe in pericolo attraverso la produzione e la distribuzione di generi alimentari avariati. Imprenditori edili utilizzano materiali scadenti con il rischio che gli edifici crollino. Operatori economici causano, attraverso speculazioni sconsiderate, il caos dei mercati finanziari. Bambini vengono rapiti, mutilati, uccisi, per commerciare i loro organi in tutto il mondo. Dietro a discutibili ricerche di biotecnologia si nascondono grandi interessi finanziari. A ciò si aggiunge il decennale scandalo dell’aborto, al quale corrisponde in maniera sempre crescente l’eutanasia. E qui mi fermo.
Tutte queste cose, che fanno ormai parte del quotidiano e quindi vengono sempre meno percepite, sono indizi di una decadenza dell’umanità e della cultura - un ritorno alla barbarie - di dimensioni quasi impensabili. É possibile - ed è questa una domanda inquietante - è possibile costruire su queste basi un’Europa in cui valga la pena vivere? Un’Europa che possiamo augurare alle generazioni future?
LA LEGGE MORALE NATURALE
È dunque arrivata l’ora della Chiesa, dei cattolici.
Al centro c’è in primo luogo la legge morale naturale, della quale la Chiesa cattolica si considera e si dimostra da sempre protagonista. La legge morale naturale non è affatto una specialità cattolica, una norma che esiste solo per i cattolici. Per questo l’annuncio etico dei pontefici si rivolge “a tutti gli uomini di buona volontà”, giacché le norme e i principi indicati non risultano solo dalla rivelazione biblica, bensì dall’essenza dell’uomo e del inondo, dalla loro natura. È in questo senso che parliamo anche di legge naturale. Contro di essa si solleva naturalmente l’energica protesta della scuola giuspositivista, che vuole riconoscere come diritto soltanto ciò che è stato dichiarato norma e legge da una autorità legislativa legittimata, qualunque essa sia.
Così, però, si spiana la strada a un relativismo incontrollabile del diritto, le cui conseguenze non possono che far fallire detta teoria.
Il dilemma del giuspositivismo diventa eclatante se si prendono per esempio i processi di Norimberga. Non può esservi alcun dubbio sul fatto che il violento regime nazionalsocialista sia giunto al potere in maniera legale. Gli organi costituzionali da esso creati avevano pertanto un potere anche legislativo -legittimo. Dunque, le leggi da essi promulgate, che vietavano i cosiddetti matrimoni misti, che ordinavano la sterilizzazione forzata dì persone affette da presunte tare ereditarie e l’uccisione di persone con disabilità mentale, e tante altre ancora, secondo il giuspositivismo erano indubbiamente norma vigente.
Era dunque legittimo processare e punire quanti avevano applicato quelle leggi? O erano solo vittime innocenti di una giustizia vendicativa delle potenze vincitrici? In sintesi, lo spunto giuspositivista porta fuori strada e conduce al caos.
Quel che rimane è la legge morale naturale, che risulta dall’ordine metafisico che abita l’intero creato ed è riconoscibile con la ragione. È ciò che la Chiesa ha annunciato sin dalle sue origini, e che è stato sviluppato e spiegato dalla filosofia e dalla teologia scolastica- t l’unica base solida della vita morale individuale e sociale.
Non era possibile non aspettarsi che la Chiesa, annunciando questa legge morale, riscontrasse una forte opposizione da parte dei diversi sistemi filosofici dell’epoca moderna, e nemmeno in futuro le cose cambieranno.
Bisogna però ricordare che, così come la natura umana è la stessa nello spazio e nel tempo, se la vita individuale e sociale deve funzionare, anche l’agire morale dell’uomo deve orientarsi a principi e norme che attraversano lo spazio e il tempo, risultanti dalla natura-persona dell’uomo.
Nell’enciclica Veritatis splendor Papa Giovanni Paolo Il osserva a tale proposito: “solo nell’obbedienza alle norme morali universali l’uomo trova piena conferma della sua unicità di persona e possibilità di vera crescita morale [...]. Queste norme costituiscono, infatti, il fondamento incrollabile e la solida garanzia di una giusta e pacifica convivenza umana, e quindi di una vera democrazia” (n. 96).
“Così, solo una morale che riconosce delle norme valide sempre e per tutti, senza alcuna eccezione, può garantire il fondamento etico della convivenza sociale, sia nazionale che internazionale” (n. 97).
Si tratta qui di un complesso di principi e di norme che - è bene ripeterlo - esisteva già molto prima di qualunque legislazione, poiché è radicato nell’ordine dell’essere stesso, e al quale ogni legislazione deve misurarsi se vuole avanzare la pretesa di essere giusta. Già Graziano affermava: “Ius autem dictum, quia iustum est”, ovvero “è diritto ciò che è giusto”, e non il contrario: “è giusto ciò che è diritto”.
LA VERITÀ
Se il primo contributo che la Chiesa può dare è il riferimento alla fondamentale importanza della legge naturale per il futuro dell’Europa, il secondo consiste nel far comprendere’ alla società che cosa significa per lei la verità.
Che la sola menzione di questo termine susciterà una tempesta di obiezioni, lo accettiamo tranquillamente. Pilato ha trovato molti successori sia nell’antichità, sia più recenti. E non c’è fine alle definizioni della verità.
Tuttavia: le - chiamiamole - correnti di pensiero filosofico ostili alla verità - poiché di sistemi non si può certo parlare - che si sono fatte sentire soprattutto a partire dal tardo XVII secolo, dovranno pure accettare che si domandi loro quali frutti sociali, culturali e politici ha dato la loro dimenticanza della verità.
Ci sono anzitutto gli utilitaristi come Thomas Hobbes, John Stewart Mill o Auguste Conte, per i quali iI criterio decisivo dell’azione umana è la sua utilità, ovvero il successo. Un esempio classico di utilitarismo applicato è il sommo sacerdote Caifa, che, tra le altre cose, giustifica la condanna a morte di Gesù dicendo che è meglio che muoia una persona sola piuttosto che soffra l’intero popolo. Che le accuse che vengono rivolte siano vere o meno non ha nessuna importanza per l’utilitarista.
Poi c’è il pragmatismo - prodotto tipicamente americano del XIX secolo -, il quale insegna che la verità non ha un significato proprio, ma risulta dall’utilità di un pensiero per affrontare le questioni pratiche. Il criterio della verità è la fattibilità. Qui va ricordato Ponzio Pilato, che crea pace e ordine a Gerusalemme, cede al popolo, libera l’idolo della folla Barabba e fa crocifiggere Gesù. Anche lui non si pone la questione della verità.
Ancor più radicale è il relativismo, che annuncia con enfasi che una verità assoluta, completa, e quindi anche norme morali generalmente valide, non esistono, che non possono esistere, poiché ogni riconoscimento dipende dalle circostanze individuali o storico-culturali, che sono in costante mutamento. Chi invece afferma di aver riconosciuto la verità, e così soggetto eo ipso al giudizio di condanna e alla dura intolleranza dei relativisti, che però, assolutizzando il loro relativismo in questo modo, lo portano all’assurdo.
Non dovrebbe essere troppo sbagliata la constatazione che le cause delle grandi catastrofi politico-culturali del XX secolo, come anche dei fenomeni attuali di decadenza appena citati, risiedono - forse anche in maniera prevalente - in questo atteggiamento mentale molto diffuso, per il quale la verità non è rilevante.
Occorre quindi porre grande enfasi sulla riscoperta dell’importanza della verità per il nostro pensiero e la nostra azione. Le domande decisive non devono essere “a che serve” o “è fattibile?”, bensì: “è vero?”, “corrisponde a verità?”. Porre questi interrogativi anche solo in relazione alla vita ecclesiale significherebbe dare un primo contributo a ciò che Benedetto XVI ha definito “liberazione dalle forme di mondanità” e che Papa Francesco esige.
La risposta presuppone necessariamente l’esistenza e la riconoscibilità di una verità sovrasoggettiva. Senza di essa, la comunicazione tra le persone o le comunità è impossibile. Senza di essa si giunge all’atomizzazione della società, nella quale poi i singoli “atomi”, ovvero le persone, stanno l’uno accanto o contro l’altro, il che non può che produrre il bellum omnium contra omnes e il homo homini lupus di Thomas Hobbes.
Le suddette correnti di pensiero dell’utilitarismo e del pragmatismo non vanno però rifiutate solo per le loro devastanti conseguenze pratiche, ma devono essere considerate insostenibili anche, e ancor più, per le loro contraddizioni interne. La verità della ragione, che nessuno mette in dubbio, sarebbe assurda senza l’esistenza e la riconoscibilità della verità. A che cosa servirebbe la ragione? Solo per dimostrare che la verità non esiste? Senza verità la ragione è inconsistente e quindi inutile.
In modo analogo, il fatto che esistono occhi e orecchie presuppone anche l’esistenza di forme e di colori, o di suoni e di rumori, se non vogliamo considerare gli occhi e le orecchie solo degli inutili capricci dell’evoluzione. Similmente, anche il relativismo porta se stesso all’assurdo. Se tutti hanno una verità individuale, è inevitabile che tante di queste verità si scontrino, si contraddicano. Ma poiché nel relativismo non esiste un criterio vincolante per il vero e il falso, ovvero il bene e il male, la conseguenza non può che essere la paralisi totale o il caos. Il relativismo si dimostra - anche per altre ragioni - una strada sbagliata del pensiero.
Di fatto esiste però l’esperienza diretta della verità, che viene confermata dalla realtà. La verità di una teoria medica viene confermata quando la sua applicazione porta alla guarigione. Se - tanto per indicare un altro esempio - è possibile, attraverso calcoli tisici-matematici, fare atterrare gli astronauti in un determinato quadrante della superficie lunare, è solo perché le leggi della fisica sulle quali poggia l’impresa e i calcoli che si basano su di esse sono veri. Poter toccare con mano, come in questi casi, l’adaequatio intellectus et rei, è un’esperienza intellettuale straordinaria!
A prescindere dal fatto che né la ragione umana, né l’universo possono essere spiegati da se stessi, ma solo come realtà creata, la cosa più sorprendente in ciò è la perfetta armonia, l’intrecciarsi, il riferimento reciproco del pensare e dell’essere, della verità e della realtà. Ciò però rimanda inevitabilmente a un’istanza che sovrasta e abbraccia tutto il pensare e l’essere, ovvero il Creator Spiritus.
LA TRASCENDENZA DI DIO
Se finora si è parlato dell’importanza fondamentale per il futuro dell’Europa - e del mondo - di una riscoperta della legge morale naturale e della verità, il riferimento appena fatto al Creatore del mondo e dell’uomo solleva il tema decisivo per antonomasia, ovvero “Dio”.
Proprio come la vita umana non può riuscire senza la legge morale naturale e il radicamento nella verità, così anche l’esistenza del inondo e dell’uomo non può essere concepita senza Dio. Si tratta dunque di rendere consapevole la società europea di oggi e di domani dei suo fondamentale riferimento trascendente.
Un individuo, una società, che non riconosce o che addirittura nega volutamente questo rapporto essenziale con la trascendenza, si preclude la dimensione decisiva dell’esistenza umana. Il fatto che a questo sia collegata, per principio, una rinuncia a ciò che è vero, buono, bello e santo, appare evidente se si tiene conto che la fonte di tutto il verum, bonum, pulchrum e sacrum finiti è il Creatore infinito ed eterno di ogni essere.
In sostanza, il contributo decisivo della Chiesa al futuro dell’Europa consiste nel tenere aperto l’accesso alla trascendenza.
IL METODO: “HUMANUM”
Forse adesso qualcuno si stupirà che, pur spiegando il contributo della Chiesa al futuro dell’Europa, finora non è stata detta una sola parola sulla fede cristiana, la rivelazione e il Vangelo, quando in fondo la nuova evangelizzazione del nostro continente è una grande preoccupazione della Chiesa.
Che non c’è stata nessuna omissione ce lo dice Papa Benedetto XVI quando parla di un “cortile dei gentili”, alludendo allo spazio davanti all’antico tempio di Gerusalemme nel quale poteva entrare anche chi non era ebreo.
Prima ancora di qualsiasi annuncio del Vangelo, infatti, la Chiesa comprende se stessa anche come avvocata dell’uomo, dell’humanum. Per questo considera come suo compito anche la riparazione delle fondamenta umane. Si muove dunque in uno spazio pre-religioso e perciò può parlare con ogni interlocutore che sia privo di pregiudizi e aperto a un dibattito razionale. In tal anodo si possono creare i presupposti per l’annuncio e l’accoglimento del Vangelo. Cercando di riportare nella coscienza della società la legge morale naturale, l’importanza della verità e il riferimento a Dio del mondo e dell’uomo, essa prepara il terreno inaridito e avvelenato dalle ideologie del XX secolo per la semina del Vangelo.
LA FORZA DELL’ARGOMENTAZIONE
La domanda che si pone ora, però, è se un tale sforzo è destinato ad aver successo. Di certo c’è che la misura dell’influenza esercitata dalla Chiesa su una società che s’intende laica è determinata prima di tutto dal numero dei fedeli e dal loro peso sociale e politico. La Chiesa ha solo l’influenza e il potere che la società è disposta a concederle, Ciò però significa anche - e vorrei qui aprire una parentesi - che i fenomeni negativi nella storia più recente dell’Europa non sono nati dalla attuazione di principi cristiani, ma piuttosto dall’allontanamento da essi. t bene ricordare anche che i politici di oggi e di domani, diversamente da quelli del tardo XIX secolo e del periodo dopo la seconda guerra mondiale, non dispongono più di un braccio politico come quello rappresentato dai partiti cristiani del passato. A ciò sì aggiunge poi che i media, che determinano l’opinione pubblica, fatte sempre più rare eccezioni, si trovano in mani che certamente non sono disposte ad aiutare la missione della Chiesa.
Che possibilità hanno, dunque, la Chiesa e i cattolici di dare il contributo appena descritto al futuro dell’Europa?
Resta loro solo la forza dell’argomentazione. E questa argomentazione - a prescindere da tutto il resto - è una domanda, per di più utopistica: che aspetto potrebbe avere questa Europa, che genere di società potrebbe nascere, che cultura verrebbe creata, se l’Europa del domani, almeno nei suoi strati pensanti, si decidesse a porre alla base del modellamento di questo continente, che si sta sempre più unificando, la Magna Charta della comprensione cattolica dell’uomo e del mondo?
Significherebbe soltanto che sarebbero la legge naturale secondo la comprensione classica, il decalogo dell’Antico Testamento e il discorso della montagna del Nuovo Testamento a costituire il metro sul quale misurare le norme per la vita sia privata sia sociale. Non c’è alcun dubbio che una tale società sarebbe di gran lunga più umana di quella dove il potere del più forte riesce a spianare la strada allo sconfinato egoismo dell’individuo, dove il più debole non ha alcuna possibilità, e dove il danaro, il potere e il piacere sono considerati gli obiettivi massimi della vita.
Se, d’altro canto, all’intoccabilità della persona, alla responsabilità del singolo per il tutto, al rispetto verso il creatore e le creature, alla dignità del matrimonio e della famiglia, si attribuisse il “rango di costituzione”, certamente non ne conseguirebbe il paradiso in terra. Tuttavia, su queste fondamenta, nonostante la fragilità delle realizzazioni terrene, potrebbe nascere una società molto più umana rispetto a quella in cui viviamo oggi. Si tratta di un’utopia come quella della “pace perpetua” di Kant? Come dimostra l’utopia marxista di una società priva dì classi, le utopie dispiegano la propria forza, che nel caso di Marx è distruttiva. Allora perché anche l’utopia di un’Europa cristiana non dovrebbe dare prova della sua dinamica modellante, costruttiva?
Intanto l’Europa può guardare indietro a un secolo di catastrofi, nate come ultime conseguenze delle ideologie nazionalsocialista e marxista, il cui errore, così ostile all’uomo, si è dimostrato in maniera tanto perentoria. Nella tragica situazione storico-culturale attuale, si pone in effetti la domanda se questa Europa scossa dalle crisi non voglia tirare fuori la curiosità e il coraggio per osare l’ “esperimento cattolico”.
Tale domanda è un appello a tutte le persone che, per la loro preparazione e posizione sociale, possono influenzare la formazione di una coscienza pubblica che perlomeno non si chiuda al messaggio cristiano. Ciò significa che ognuno di noi, nel proprio ambito di vita, deve sostenere questo obiettivo con consapevolezza e tenacia.